Investimenti e visione, per una sovranità tecnologica europea
A colazione con
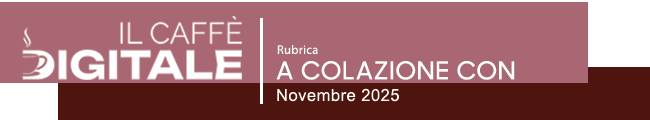

La discussione sulla sovranità digitale europea evidenzia una contraddizione ancora irrisolta: la capacità di regolamentare cresce, mentre quella di costruire tecnologie autonome rimane limitata. La distanza tra ambizione e capacità industriale emerge in campi come l’intelligenza artificiale, il cloud e le tecnologie di frontiera come il quantum computing, dove la competizione globale richiede investimenti costanti e infrastrutture proprie.
A margine del suo intervento sul palco del Digital Italy Summit 2025, a metà novembre, abbiamo incontrato Alec Ross nelle sale monumentali dell’Acquario Romano. Nato e cresciuto a Charleston negli Stati Uniti, ma con una famiglia di origini italiane, Ross è analista di mercato e autore di bestseller sui temi della tecnologia, noto in tutto il mondo attraverso i suoi libri e oggi anche professore alla Bologna Business School. Il punto di partenza della chiacchierata è stato il messaggio centrale del suo keynote speech: l’Europa dispone di molti talenti e di idee solide, ma fatica a trasformarli in sistemi tecnologici scalabili. Ed è proprio in questo divario tra visione e capacità produttiva che si gioca la possibilità di un ruolo del nostro continente nelle tecnologie emergenti.
Alec Ross, quando si parla di sovranità digitale, spesso in Europa si insiste sulla regolamentazione. Secondo lei, cosa servirebbe per avere un controllo reale su dati e infrastrutture?
La regolazione non basta, anzi rischia di diventare un esercizio burocratico che dà l’illusione di proteggere i dati senza cambiare nulla nella sostanza. Tutti quei banner sui cookie fanno sorridere noi statunitensi: sembrano proteggere la privacy, ma in realtà non determinano alcun effetto. Se l’Europa vuole la sovranità digitale, credo la via sia una sola: smettere di usare gli strumenti degli altri e cominciare a costruire i propri. Significa investire in piattaforme e infrastrutture europee, non limitarsi a conferenze stampa, report o post sui social. Negli ultimi 10-15 anni l’approccio è stato troppo formale e poco concreto: molta retorica, pochi investimenti veri. La sovranità si conquista creando tecnologie, non regolando quelle altrui.
L’iniziativa Gaia-X per un’infrastruttura dati europea è stata per anni presentata come un progetto strategico. Come mai, dal suo punto di vista, non ha portato ai risultati attesi?
Il progetto Gaia-X è stato soprattutto un grande esercizio comunicativo. C’erano conferenze stampa, rapporti, tavoli di lavoro, ma non la spinta economica e politica necessaria a costruire davvero un’infrastruttura europea. È mancata la sostanza: nessuno ha investito con la determinazione che serve quando si vuole creare un’alternativa alle big tech globali. Il progetto avrebbe potuto diventare un pilastro della sovranità europea, ma si è fermato a livello teorico. È l’esempio tipico di un approccio generale: tanta narrativa, poca ingegneria e pochi capitali. Se si vuole competere, bisogna accettare che tecnologia significa investimenti massicci, continuità e rischi. Senza queste tre condizioni Gaia-X non aveva alcuna possibilità di trasformarsi da progetto politico a infrastruttura reale, ed era inevitabile che rimanesse un’iniziativa incompiuta.

Guardando all’intelligenza artificiale, quali filoni della competizione globale ritiene ormai persi per l’Europa, e quali invece restano ancora aperti?
L’Europa ha certamente perso terreno nell’AI legata alla raccolta dati e in quella generativa, settori ormai dominati da colossi statunitensi e cinesi capaci di investire in modo massiccio e continuativo. Ma questo non significa che tutto sia compromesso. Esistono ancora due ambiti fondamentali, l’intelligenza artificiale agentica e l’AI fisica, che uniscono software e capacità d’azione nel mondo reale e che si trovano ancora in una fase iniziale di sviluppo. È proprio qui che l’Europa potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista, a condizione però di avere il coraggio di investire con serietà e di farlo senza esitazioni. Il talento, infatti, non manca: lo vedo nei giovani, nei ricercatori, nelle università con cui collaboro quando mi trovo in Italia o altrove nel continente. Ciò che oggi manca davvero è un impegno strutturale, fatto di continuità, risorse adeguate e una visione che vada oltre i documenti programmatici e le dichiarazioni di intenti. La partita, insomma, non è affatto chiusa, ma va affrontata adesso, con determinazione e con investimenti che abbiano un peso reale.
Un’altra tecnologia sulla cresta dell’onda è il quantum computing, su cui vediamo molti annunci – soprattutto dalle big tech – ma un po’ meno investimenti europei. Cosa serve per restare davvero in questa partita?
Il quantum computing è un settore in cui gli annunci, se non sono accompagnati da investimenti veri e consistenti, finiscono per non avere alcun valore. Negli Stati Uniti, in Cina, in India o nei Paesi del Golfo, ogni dichiarazione pubblica viene seguita da un impegno economico enorme, che permette ai progetti di crescere e consolidarsi. So di ripetermi, ma in Europa invece troppo spesso dopo la conferenza stampa non accade praticamente nulla, e questo rivela un limite culturale prima ancora che finanziario, perché si tende a confondere la comunicazione con l’azione. Serve un cambio di mentalità, meno orientato al rituale e più all’efficacia, perché l’innovazione non è un momento da celebrare, ma un lavoro costante che va sostenuto giorno dopo giorno.
Lei ha un legame profondo con l’Italia e sostiene molte iniziative nel nostro Paese. Cosa la convince del nostro potenziale?
Il mio legame con l’Italia è fortissimo, personale e professionale. Amo questo Paese senza condizioni: la cultura, le persone e persino le sue contraddizioni. Negli anni ho sostenuto il più grande investimento di un fondo statunitense in una startup digitale italiana, e ogni giorno mi chiedo cosa posso fare per contribuire a fare crescere questo ecosistema. Qui c’è un potenziale straordinario: talenti brillanti, creatività, capacità tecnica, ma manca quel senso di autodeterminazione che spinge a non aspettare Roma o Bruxelles per risolvere i problemi. Per dirla con una battuta, credo servirebbe meno cultura del notaio e più cultura del cowboy, ossia più coraggio nel rischiare, sperimentare, costruire. L’Italia ha tutto per diventare un modello: deve solo imparare a fidarsi del proprio potenziale e a liberare l’energia che già possiede. È una delle ragioni per cui il mio prossimo libro, che si chiamerà The Italian Dream e uscirà nella primavera 2026, è tutto dedicato a questo Paese.


