Mezzo secolo di AI per ripensare la medicina
A colazione con
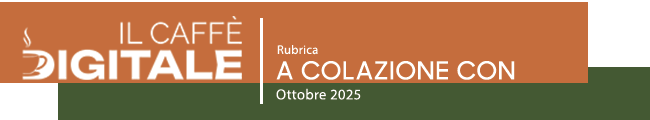

L’intelligenza artificiale sta trasformando la sanità molto più in fretta di quanto il sistema sanitario riesca ad adattarsi alle novità che si rincorrono. Dalle diagnosi assistite ai modelli predittivi, fino agli algoritmi che analizzano milioni di immagini e referti, l’AI promette di alleggerire il carico dei clinici e migliorare l’assistenza, ma solleva anche nuove sfide che spaziano dalla gestione dei dati alla sicurezza fino alla responsabilità delle decisioni automatizzate. In un momento in cui la corsa globale alla digital health sta ridisegnando gli equilibri tra ricerca, industria e governance, comprendere come integrare la tecnologia nella pratica quotidiana è diventato cruciale.
Tra le voci più autorevoli al mondo in questo dibattito c’è John Halamka, medico, imprenditore e presidente della Mayo Clinic Platform, che raggruppa una serie di iniziative notevoli di medicina digitale. Da oltre trent’anni – oggi ne ha 57 – Halamka lavora all’intersezione tra medicina, informatica e policy, guidando progetti pionieristici per la condivisione sicura dei dati e l’uso etico dell’intelligenza artificiale in sanità, come ha raccontato anche nel suo recentissimo libro Transform: Mayo Clinic Platform and the Digital Future of Health (2025). Abbiamo incontrato Halamka a margine dell’intervista esclusiva (qui da 1:29:00) raccolta in occasione dell’Healthcare Innovation Summit 2025, l’appuntamento autunnale di TIG (The Innovation Group) e AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità) per discutere il futuro del digitale per il comparto della sanità e delle scienze della vita.

John Halamka, quali sono secondo lei le tappe fondamentali che hanno portato l’AI alle applicazioni cliniche di oggi?
Lavoro sull’intelligenza artificiale da decenni, e in questo tempo sono cambiate radicalmente sfide e opportunità. All’inizio il problema era far funzionare le macchine: le risorse di calcolo erano limitate e spesso occorreva costruirle da zero. Poi l’attenzione si è spostata sul software, sui linguaggi e sugli strumenti che permettevano di dare istruzioni ai computer e di farli ragionare. In quegli anni venivano sperimentati sistemi basati su regole che, con il senno di poi, anticipavano alcuni meccanismi dei chatbot moderni. Pian piano l’intelligenza artificiale ha iniziato a entrare nel mondo della sanità, grazie alla creazione delle prime cartelle cliniche elettroniche e alla raccolta di dati strutturati su problemi, farmaci e referti. Questo passaggio è stato decisivo: senza dati affidabili e comparabili non può svilupparsi un’AI clinica efficace. Da lì è emersa la necessità di far dialogare i diversi sistemi informatici, definendo standard comuni e piattaforme capaci di condividere informazioni in modo sicuro e interoperabile. Oggi, dopo decenni di evoluzione, il settore dispone finalmente di tutto ciò che serve per applicare l’intelligenza artificiale alla pratica medica quotidiana: potenza di calcolo, grandi quantità di dati e un linguaggio comune per interpretarli.
La disponibilità e la qualità dei dati sanitari sono un punto chiave per lo sviluppo dell’AI: quali sono le principali difficoltà nel rendere questi dati utilizzabili in modo sicuro e standardizzato a livello globale?
Il problema non è solo raccogliere dati, ma renderli davvero utilizzabili senza violare la privacy. La maggior parte delle informazioni cliniche utili — come note, referti, immagini — non è strutturata e contiene molti dettagli personali difficili da eliminare. Non basta togliere nomi o numeri di cartella: anche un ruolo, una data o un evento specifico possono rendere una persona riconoscibile. Per questo abbiamo sviluppato tecniche che modificano o mascherano questi elementi, come lo spostamento delle date o la sostituzione di parole troppo identificabili, così da mantenere il significato clinico ma proteggere l’identità dei pazienti. Lo stesso vale per le immagini mediche: un esame del cranio, per esempio, può essere ricostruito in 3D e mostrare il volto, quindi viene leggermente sfocato. Solo dopo un lavoro di questo tipo i contenuti possono essere archiviati e analizzati in ambienti cloud sicuri, conformi alle normative internazionali come il GDPR in Europa e l’HIPAA negli Stati Uniti.
L’Europa sembra procedere più lentamente rispetto ad altre aree del mondo. Quali passi concreti servirebbero per accelerare l’adozione dell’AI in sanità senza compromettere sicurezza e regolamentazione?
Non voglio essere eccessivamente critico, ma l’Europa oggi è davvero indietro. Negli ultimi mesi ho visitato 21 paesi, e in molti ho sentito dire che si attende l’European Health Data Space. È di certo una buona iniziativa, ma se si resta fermi fino al 2028 il resto del mondo sarà già ben più avanti. Il mio consiglio è di non aspettare: in Asia, in Medio Oriente e in molte parti dell’America si stanno già adottando soluzioni di AI a scala. In Europa ci sono stati che si muovono meglio, come Danimarca o Paesi Bassi, ma manca un approccio coordinato. La chiave potrebbe essere la creazione di un modello federato: così i dati rimarrebbero nei singoli centri, e sarebbero gli algoritmi a spostarsi. Questo permetterebbe di sviluppare modelli condivisi riducendo rischi, costi e tempi.
Mayo Clinic Platform è spesso citata come modello di cooperazione tra ricerca, startup e grandi aziende. Qual è la lezione più utile che può offrire a chi vuole costruire ecosistemi digitali simili?
Alla Mayo Clinic abbiamo cercato di costruire qualcosa che mettesse davvero in relazione informazioni, ricerca e innovazione. Dopo aver anonimizzato e messo in sicurezza enormi quantità di dati clinici, abbiamo aperto la piattaforma a collaborazioni con startup, aziende e istituzioni. Una sessantina di giovani imprese sono passate dal nostro acceleratore, e alcune di loro oggi sono diventate realtà globali. Anche grandi aziende e 26 case farmaceutiche hanno usato la piattaforma per validare modelli, studiare nuovi target terapeutici o analizzare coorti di pazienti. Oggi oltre 60 sistemi ospedalieri nel mondo utilizzano applicazioni nate da queste collaborazioni, integrate direttamente nelle cartelle cliniche attraverso un sidecar che le fa funzionare nel flusso di lavoro reale. È un circolo virtuoso: più attori partecipano, più valore si genera per tutti. La lezione principale è proprio questa: creare fiducia, condividere conoscenze e costruire sistemi dove ogni parte contribuisce e beneficia della presenza delle altre.
Guardando al futuro, come immagina il ruolo dell’AI nella pratica clinica quotidiana? E quanto siamo vicini da una vera intelligenza artificiale generale?
Credo che entro cinque anni ogni medico utilizzerà l’intelligenza artificiale nella propria attività quotidiana. Non per sostituirsi al giudizio clinico, ma per affrontare l’enorme quantità di dati che arrivano da pazienti, referti e letteratura scientifica. L’AI diventerà un supporto indispensabile per prendere decisioni migliori e più rapide. In un certo senso, non usarla significherà lavorare con meno strumenti di quanti se ne avrebbero a disposizione. Quanto all’intelligenza artificiale generale, sono molto più prudente: i modelli attuali sono straordinariamente utili, ma non ragionano, non hanno intenzione o consapevolezza. Aumentare la quantità di dati o la potenza di calcolo non sarà sufficiente. Servirà un cambio di paradigma, qualcosa di ancora lontano. Nel frattempo, l’obiettivo è continuare a usare l’AI come alleato dei clinici, riducendo il carico amministrativo e migliorando la cura del paziente.


