Il “premio Nobel dell’informatica” dalle origini italiane
A colazione con
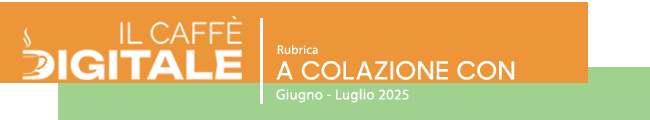

La matematica e l’informatica sono tra le più importanti discipline della scienza e dell’innovazione a non avere un proprio premio Nobel. Se l’equivalente del “Nobel per la matematica” è considerato essere la Medaglia Fields, per l’informatica il riconoscimento globalmente più autorevole è senz’altro il Premio Turing, il cui albo d’oro dei vincitori annovera negli ultimi anni personalità come Robert Metcalfe, Avi Wigderson, Andrew Barto e Richard Sutton. A meritarlo nel 2021 è stato un informatico statunitense, che però ha origini italiane: in Sicilia il suo cognome sarebbe stato probabilmente Don Garrà, o forse Dongarrà. Nel Nordamerica è diventato Dongarra, senza accento.
Con Jack Dongarra abbiamo fatto merenda in un bar a Lindau, cittadina della Baviera sul Lago di Costanza, in suo un momento di pausa dagli impegni ufficiali. A portarlo su quell’isoletta è stato il 74esimo Nobel Laureate Meeting, in cui ha tenuto una approfondita lectio dedicata alla storia e al presente delle tecnologie della computazione, inclusi gli aspetti di mercato (per i più curiosi, la versione integrale è disponibile qui). Tra i numeri più notevoli, a fine giugno 2025 NVIDIA ha raggiunto una capitalizzazione di mercato che sfiora i 4mila miliardi di dollari, superando Microsoft, Apple e Amazon. I colossi storici dell’hardware, come Lenovo, IBM, HPE e Fujitsu, sommati insieme, non arrivano a 2.200 miliardi. Insomma, siamo di fronte a una rivoluzione dei valori economici in gioco, anche di fronte al caffè si è parlato anzitutto di vicende di vita.
Dalla sua storia personale emergono molte connessioni con l’Italia, anche affettive: che rapporto ha oggi con il Belpaese?
Le mie radici italiane sono sempre state importanti, anche se sono cresciuto negli Stati Uniti. Le famiglie dei miei genitori, ossia i miei nonni, erano originarie della Sicilia, da due piccoli paesi nell’entroterra: Villarosa e Santa Caterina Villarmosa, a cavallo tra le province di Caltanissetta e di Enna. Non si conoscevano prima di emigrare oltreoceano, tanto che i miei genitori si sono conosciuti da ragazzi solo una volta arrivati a Chicago, nello stesso quartiere italiano dove poi sono nato io. Oggi quella zona di Chicago è scomparsa, trasformata per lasciare spazio a una delle sedi universitarie della città. Della Sicilia conservo ricordi molto vivi, anche grazie a un viaggio fatto qualche anno fa con mia madre, durante il quale siamo riusciti a ritrovare la casa dove vivevano i miei nonni materni, i suoi genitori. È stato un momento molto speciale. Di mio papà Giuseppe invece conservo i documenti del viaggio verso gli Stati Uniti, quando lui aveva dieci anni.
L’Italia continua a essere presente nella sua vita?
Non parlo italiano fluentemente perché mio padre voleva che noi figli ci integrassimo pienamente nella società americana, ma ho sempre sentito un forte legame culturale con l’Italia. Roma, in particolare, è una delle città dove torno più volentieri e mi capita spesso di passare qualche giorno in Italia, anche per lavoro: ho un incarico all’Università di Manchester e in estate mi sposto nel Regno Unito per un periodo ogni anno. A volte, questi soggiorni coincidono con incontri internazionali o con progetti di ricerca condivisi, che mi permettono di mantenere vivi anche i rapporti accademici. L’Italia per me rimane sempre un posto familiare, anche se ormai il mio lavoro mi porta davvero ovunque. Il legame non è solo personale, ma anche professionale: qui ritrovo un modo di pensare e collaborare che mi affascina.
Passiamo dalle sue vicende specifiche ai temi più generali: come vede oggi il valore della cooperazione internazionale nello sviluppo tecnologico e digitale?
Per me è sempre stato fondamentale lavorare con persone provenienti da contesti diversi, perché l’innovazione vive proprio di confronto, apertura e scambio di idee. Ho avuto, e continuo ad avere, collaborazioni molto attive con colleghi in Europa, in Giappone, in Australia, e ogni cultura porta una prospettiva unica che arricchisce enormemente sia il processo di sviluppo sia l’efficacia dei risultati. Purtroppo, non sempre è possibile lavorare con tutti: con la Cina, per esempio, le attuali tensioni geopolitiche hanno reso più difficile lo scambio, soprattutto per quanto riguarda tecnologie strategiche e dati sulle infrastrutture, anche se resta forte la volontà di costruire ponti. La mia idea è che la comunità scientifica e degli innovatori debba mantenere una cultura della trasparenza, condividendo esperimenti, metodi, risultati – anche i software – come modo per garantire qualità, replicabilità e progresso. Io stesso pubblico il codice che sviluppo con licenze molto aperte, perché trovo giusto che sia accessibile al maggior numero possibile di ricercatori. Se chi fa scienza rinuncia alla collaborazione, perde una parte essenziale del proprio ruolo. In un’epoca in cui le sfide globali sono così complesse, abbiamo più che mai bisogno di soluzioni condivise.
I giovani ricercatori si stanno formando in un contesto tecnologico in rapido cambiamento. Quali competenze sono fondamentali per affrontare una carriera nel supercalcolo e nella programmazione?
Chi si affaccia alla scienza computazionale deve saper combinare solide basi teoriche con un atteggiamento aperto alla sperimentazione. Naturalmente servono competenze in matematica, in algoritmica e in programmazione, ma direi che è altrettanto importante la capacità di adattarsi rapidamente, perché gli strumenti cambiano di continuo. È utile conoscere i fondamenti dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni, ma ancora di più è sapere come applicarli in contesti reali. Un altro aspetto che considero cruciale è il lavoro di squadra: quasi nessun progetto rilevante può essere portato avanti da soli. Infine, aggiungerei una certa sensibilità all’open science – saper documentare, condividere codice, validare risultati – perché la trasparenza è parte integrante del metodo scientifico, soprattutto in un’epoca in cui tutto è più veloce, ma anche più complesso. Chi lavora oggi in questo campo deve essere, prima di tutto, curioso e pronto a imparare sempre.
Guardando ai prossimi anni, quale pensa sarà il cambiamento più radicale nell’ambito delle tecnologie di supercalcolo?
Credo che il cambiamento più radicale sarà la crescente integrazione tra modelli tradizionali di calcolo e sistemi basati su intelligenza artificiale. Finora abbiamo usato il supercalcolo per simulare fenomeni fisici con tecniche ben codificate, fondate su principi matematici solidi. Oggi l’intelligenza artificiale ci consente di costruire approssimazioni veloci, utili per esplorare scenari complessi o ridurre i tempi di elaborazione. In futuro, vedremo sempre più spesso una combinazione dei due approcci: l’intelligenza artificiale ci aiuterà a generare ipotesi, restringere lo spazio delle soluzioni e guidare esperimenti, mentre i metodi numerici tradizionali continueranno a fornire robustezza e rigore.


